IN QUESTI GIORNI, come è normale nel gioco democratico data la rilevanza della questione, sono in molti gli iscritti a parlare della questione ex Lucchini-Aferpi.
Fanno parte del cospicuo elenco soggetti singoli e organizzati che hanno titolo, ruolo, competenze e vissuto per affrontare debitamente l’argomento; alcuni altri che quando noi difendevamo il lavoro con la lotta e le proposte non hanno mai lasciato il divano e oggi fanno i professori; alcuni ancora che fanno finta di non ricordare il succedersi degli eventi; altri che per calcolo o diletto, anche utilizzando i social media, si preoccupano unicamente di appestare l’aria.
A beneficio delle persone in buona fede (che notoriamente sono la maggior parte e sanno distinguere) vale la pena ricordare che Issad Rebrab sale le scale del Comune di Piombino verso il luglio del 2014. Per quel che risulta – avevo già lasciato via Ferruccio – lo fece di propria iniziativa e senza preventivi contatti con le istituzioni, attratto dagli imponenti lavori avviati sul porto a valle dell’Accordo di Programma dell’agosto del 2013. Un accordo che costruimmo con Regione e ministeri e che seguì un decreto legge e la sua conversione avversati duramente dalle opposizioni al PD in Parlamento.
È lecito supporre che la determinazione dell’industriale algerino si fosse rafforzata a seguito della stipula del successivo Accordo dell’aprile del 2014, che firmai a Palazzo Chigi con Matteo Renzi ed Enrico Rossi e che metteva a disposizione del territorio ingenti risorse regionali, statali e comunitarie per la riconversione, l’innovazione industriale, le bonifiche, la diversificazione. In tutto circa 260 milioni: vale la pena rammentarlo a chi sostiene che si era lasciato poco.
La fermata dell’area a caldo dello stabilimento aveva seguito una stagione di mobilitazione compatta dell’intero territorio volta prima a difendere il lavoro e poi a chiedere una prospettiva alternativa alla produzione siderurgica tradizionale della quale era emersa la progressiva insostenibilità economica. L’Accordo di Programma fu l’esito di quel periodo così sofferto e socialmente partecipato, che non poté concludersi per condizioni oggettive con quel mantenimento della continuità produttiva, da noi a lungo invocato e supportato da proposte, che ci consentisse di agganciare la nuova fase.
La procedura pubblica di selezione del nuovo acquirente della ex-Lucchini, esperita dal Commissario Straordinario incaricato dal Governo, condusse alla scelta di Cevital, multinazionale algerina giudicata portatrice di un progetto ambizioso e diversificato di gran lunga preferibile a quello minimale degli indiani di Jindal-Federacciai (solo i laminatoi, 7-800 addetti complessivi) e solida di un comprovato standing finanziario e patrimoniale.
L’entusiasmo e le speranze suscitate nel territorio, con la consueta eccezione dei perplessi abituali e degli incrollabili aruspici del disagio, furono larghi e ben motivati di fronte alla promessa di un risarcimento e di una rivincita dopo anni di battaglie e sofferenze.
Dal mio osservatorio in quel momento distante dalla prima linea gioivo al pensare che l’imponente lavoro personale e collettivo compiuto sul terreno della tenuta politica e sociale da un lato, sul piano amministrativo (gli Accordi) dall’altro, aveva creato le condizioni per una ripartenza su basi nuove.
La soddisfazione era temperata dalla frustrazione di non poter mettere a disposizione del territorio le conoscenze e le relazioni che avevo accumulato nel tempo (in una prima fase, nel 2014, mi era stata proposta la gestione dell’Accordo di Programma poi si optò per soluzioni alternative); tuttavia ho accompagnato, seguito attentamente e sostenuto questo percorso, nonostante sulla questione non abbia avuto un ruolo diretto neanche dopo la mia elezione in Regione. Se lo avessi avuto si sarebbe visto.
Scrivo queste cose non perché mi appassioni guardare al passato, esercizio che è proprio degli sconfitti; ma perché leggo alcune ricostruzioni di ciò che ci sta alle spalle sospese fra il fantasioso, l’immemore e il meschino e non mi pare giusto lasciar correre.
Per quanto riguarda invece l’oggi e il domani, che sono l’unica cosa che conta:
– mi pare positivo che il ministro Calenda abbia chiesto a Rebrab termini stringenti su piano industriale e cronoprogramma. Ho detto nei giorni scorsi che è giusto svolgere tutte le verifiche sul progetto di Rebrab, ma non necessariamente oltre il tempo che consenta di restare vivi e immaginarsi ragionevolmente nel domani. Si cominciano a raccogliere le macerie di mesi trascorsi senza realizzazioni, che non risultano nemmeno imminenti; e come affermò un economista molto in gamba “nel lungo periodo siamo tutti morti”.
– Rebrab ha avuto 4 mesi per firmare un contratto preliminare a Palazzo Chigi (novembre 2014), e altri 8 mesi prima della stipula definitiva dal notaio (luglio 2015). Si può capire il cuore oltre l’ostacolo nella primissima fase, ma è difficile pensare che dopo un anno di valutazioni un grande gruppo multinazionale si getti in un’impresa così ambiziosa senza aver preventivamente definito piani industriali e coperture finanziarie. Se sono mutate alcune condizioni di scenario lo si dica. Se vi sono problemi a spostare capitali dall’Algeria lo si dica. Se per il progetto siderurgico Cevital non dispone di mezzi propri e se il sistema bancario lo ritiene troppo oneroso e incerto lo si dica, e ci si concentri su ciò che si può far partire. Demolizioni, agroalimentare, logistica.
– per la parte siderurgica, riterrei opportuno valutare il ricorso transitorio e ponte al Fondo Strategico della Cassa Depositi e Prestiti; in caso di impossibilità di intervento dello Stato è necessario comunque scongiurare la fermata dei laminatoi.
– i laminatoi, appunto, sono sostanzialmente scarichi di lavoro e questo rischia di compromettere l’accordo raggiunto sui contratti di solidarietà. Nel breve termine è necessario assicurare la continuità produttiva coprendo finanziariamente il circolante e mettere mano alle demolizioni. Ho parlato con Enrico Rossi di questi temi e stiamo valutando come Regione Toscana quali azioni intraprendere d’intesa con Governo e Comune.
– tuttavia la continuità produttiva senza una prospettiva certa di tipo industriale rischia di rivelarsi un ponte verso il nulla; dunque si torna alla necessità di chiarire quali investimenti, in quali tempi, con quali implicazioni territoriali e urbanistico-ambientali (a cominciare dalle bonifiche).
– infine vale la pena ribadire che è serio e responsabile non parlare solo di acciaio. Si può comprendere che lo faccia chi vive di quello, ma anche fra quelle persone esiste la consapevolezza che senza tenere la barra sulla despecializzazione economico-produttiva e il rafforzamento di PMI manifatturiere, turismo, agricoltura e servizi non si andrà lontano.
P.s.: Differenziare l’economia di un territorio, che per sua natura è una entità tanto più rigida quanto più secolare è stato il suo modello di sviluppo, è un processo complesso, graduale e impegnativo.
A chi da sempre parla di diversificazione economico-produttiva non banalizzandola ma facendo i conti con spessore e qualità di argomenti con quella complessità, e a coloro che l’hanno praticata con fatica talvolta subendo processi settari credo dovremmo essere tutti intellettualmente riconoscenti.
(30 dicembre 2016)




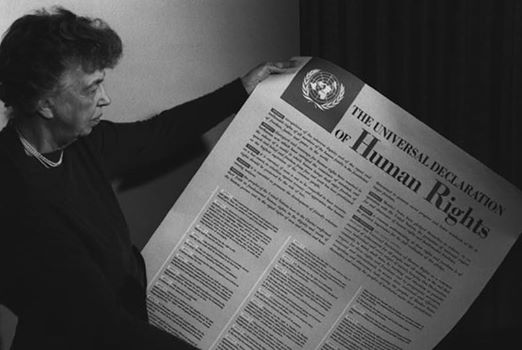




Post your comments